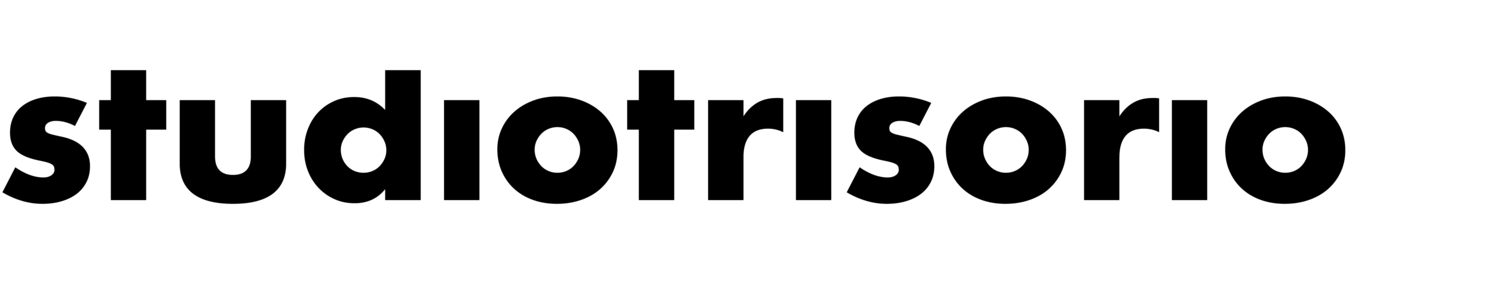Gregorio Botta quel respiro dell’arte che racchiude l’infinito
la repubblica napoli / 27 settembre 2021
Stanze di-stanze. È lo spazio che colma la distanza tra noi nel mondo e noi stessi rivolti ai nostri umani “interiors”, quello che vediamo quando entriamo nelle sale di “Breathe in”, la personale di Gregorio Botta allo Studio Trisorio (inaugurazione mercoledì alle 18; Riviera di Chiaia, 215). Che cos'è infatti che ci unisce al mondo, se non il respiro: invisibile, impalpabile soffio testimonianza della nostra esistenza in vita, di cui è primo e ultimo segno. Quel segno, tra parentesi, che questa pandemia ci ha fornito nuovamente perché riacquistassimo il concetto di morte del corpo che avevamo perduto. Luoghi che racchiudono luoghi dove meglio guardare l'infinito. E la prima dimensione che s'incontra è la miniatura: piccoli larari o tabernacoli, micro-angoli di mondo che preludono a spazi non delimitati: «Volevo racchiudere in un perimetro e un volume qualcosa che potesse contenere l'infinito», spiega l'artista. Con-tenere, ossia tenere insieme, per poter contemplare. Botta fa riferimento anche alle formelle con bassorilievi in terracotta di Arturo Martini, fatti di pieni e di vuoti, e raffiguranti interni abitati. Ciò che il grande critico Georges Didi-Huberman, citato anche nel bel testo di Marinella Paderni che accompagna la mostra, ipotizza quando parla di “gioco delle evidenze” e azionando un ossimoro: non c'è evidenza se non per ciascuno di noi. La scultura – volume e rappresentazione – ha “evidenza”, ma Gregorio Botta intende ricorrere a un disvelamento, mostrandone anche l'atto, non soltanto quel che ne consegue.
Si è invitati o forse sollecitati a guardare oltre, o addirittura è naturale, questo oltrepassare una soglia solo indicata. Ed ecco allora le quattro forme scultoree di Angeli, entro la cui pelle di cera scrutare per scorgere un ambiente che ospita le piccole coppe (spesso usate dall'artista nei suoi lavori), o addirittura gangli di ambienti, illuminati da quelli che nel sud d'Italia vengono detti “lumi ingredienti”, finestre obbligate in alternativa alle tenebre. O addirittura l'immagine riflessa di una coppa, a “sfondamento” dell'orizzonte dello sguardo: verso l'infinito. Non sono case, che sarebbe una definizione che obbliga. Nello spazio di pochi centimetri – è la magia della miniatura – la luce per asserzione dell'artista diventa la lama di sole degli interni di Vermeer (la Donna che legge una lettera ma più ancora la Donna che scrive una lettera alla presenza della domestica) ma forse ancor più quella straordinaria emanata dalla figura apparsa nell'ultimo restauro solo della Vocazione di San Matteo di Caravaggio, che è una delle “Aberrazioni” visive di cui parla nel suo libro omonimo il critico lituano Jurgis Baltruŝaitis: figura in cui i critici hanno creduto di intravedere un angelo. Quindi saremmo in tema.
Gregorio Botta, classe 1953, è nato a Napoli e vive e lavora a Roma. È stato vicedirettore di Repubblica. La Gnam, Galleria nazionale dell'arte moderna di Roma, nel 2020 gli ha dedicato una personale dedicata al la memoria del critico d'arte Lea Mattarella. Una sua opera è installata nella stazione della Linea 1 del Metrò dell'arte “Vanvitelli” e un'altra al Museo Madre. La sua ricerca è caratterizzata dal rendere un concetto che va oltre la materia, pur usando materiali concreti. “Come tradurre – si domanda Marinella Paderni in un'immagine riverberante la leggerezza – la corporeità senza peso?”. Botta “esplora l'imponderabità rivelando la sua natura meta-reale, quella più segreta e difficile da nominare, ricorrendo alla trascendenza che la materia del mondo può trasferire alle cose”.
La mostra continua come un viaggio interiore, che ha il suo corrispettivo in un'altra tappa protesa verso l'esterno, “Breathe out”, l'altra personale collegata a quella di Napoli che Botta tiene in contemporanea allo Studio G7 di Bologna. A parete, di fronte agli Angeli, che sono parallelepipedi poggiati su piccole impalcature metalliche, solidi essenziali che nascondono un'anima di carton gesso o altro materiale rigido racchiuso in una colata di cera bianca, che invece è liquido e fluido «come noi, come la nostra corporeità», dice Gregorio Botta, sono apposte quattro lastrine di alabastro, sul cui retro l'artista ha procurato delle incisioni inserendo fiori, foglia d'oro, sovrapposizioni cromatiche. L'alabastro è un filtro di colore dove prevale l'opaco, e la materia quasi impalpabile che occupa il retro, chiede quasi di uscire, come un fossile «vivo», raccomanda Botta, come viva è anche l'acqua che scorre sulla lastra di cera della fontana nella seconda sala, concepita come un hortus conclusus che al centro ospita un pozzo. Anche in questo caso, ciò e di che è “concluso” non finisce e non è contenuto, in quanto aperto verso il cielo e vivificato dai fiori in ceramica, presumibilmente convolvoli (in latino “avvolgere”, dal portamento della pianta, rampicante, che qui ha lasciato soltanto i boccioli). I rivoli d'acqua, distinti ma non incompatibili con l'altra materia, la cera, una sorta di glassa grassa, scendono lungo due diversi tracciati, scelti dall'acqua spontaneamente e autonomamente, a testimonianza che l'elemento è vivo. Alle pareti stanno fogli di carta di riso e cera “impressionati” – come se fossero carta fotografica – con parti di fiori, tracce di foglie e steli accanto a piccole gocce di sangue. Un prato doloroso come quello che Beato Angelico dipinse sotto i piedi di Gesù e della Maddalena nel Noli me tangere (Non mi trattenere) del convento di San Marco a Firenze. Infine Hölderlin Paradise è una visione romantica del paradiso dantesco, tra le immagini più difficili da immaginare e rappresentare: cerchi in vetro su cui sono sparsi piccoli fiori in terracotta modellati dall'artista. L'unico luogo, il paradiso, ove la trasparenza evocata è assoluta, e non filtrata, priva di opacità. «È un'opera – racconta Gregorio Botta – in qualche modo connessa al Romanticismo, laddove il poeta tedesco fa riferimento al concetto che “ogni ferita dà luogo a una cura”».
Renata Caragliano e Stella Cervasio