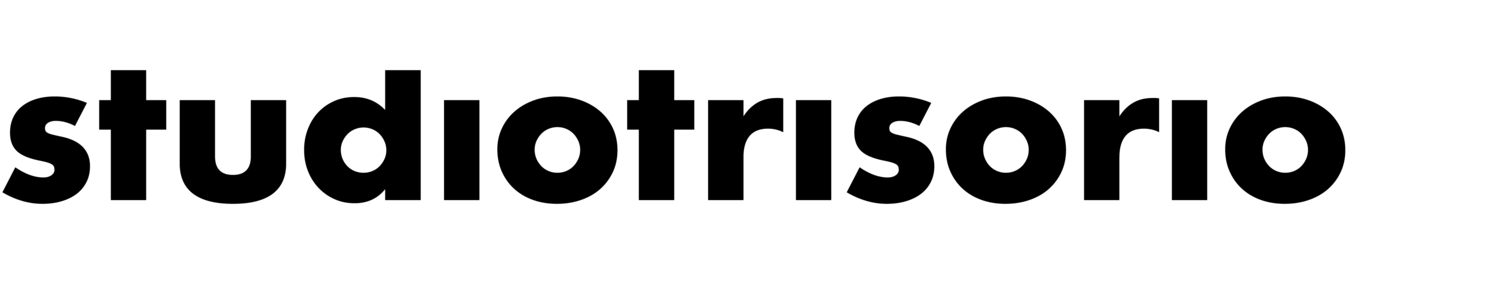Paul Harrison & John Wood Roma | Napoli, Studio Trisorio
exibart / 4 marzo 2009
Sembra d’essere finiti nella stanza bianca delle Quattro immagini uguali (1969) di Giulio Paolini, con l’unica differenza che ora, nella stanza bianca, c’è uno spettatore seduto su una sedia che osserva un’altra stanza bianca, visibile da uno schermo. Il white cube di John Wood (Hong Kong, 1969; vive a Bristol) & Paul Harrison (Wolverhampton, 1966; vive a Londra, Bristol e Wolverhampton) è proiettato per la prima volta nello Studio Trisorio a Roma e contemporaneamente negli spazi di Napoli, proponendo principalmente video-istallazioni, tra cui Twenty six drawing and falling things per la Capitale e The Only Other Point per la città partenopea.
Concentrandoci sulla prima, la coppia inglese – attiva dal ‘93 – immobilizza il fruitore in un’ipnotica stanza svuotata dalla “quarta parete”, in cui il bianco trionfa sugli abiti neri dei due artisti, perenni interpreti delle loro azioni. Ventisei inquadrature dalla singola durata di non più d’un minuto compongono l’immagine frontale di un documentario minimalista ed essenziale, in cui le forme geometriche si alternano a oggetti d’uso comune, confrontandosi con la dimestichezza passiva del duo.
Prima singolarmente e poi in coppia, Harrison & Wood giocano con “linee di forza” nere che, dietro di loro, tagliano orizzontalmente il bianco dello sfondo per attraversarlo diagonalmente e, infine, passar loro davanti, all’altezza del busto; questa volta, però, è la linea stessa a cedere, cadendo a terra dopo il taglio netto di una forbice. E quando la geometria materica lancia il suo ultimo sfogo, coinvolgendoli con il dondolio di un semicerchio grigio, il colore entra in scena con l’oggetto: una scatola di cartone si affloscia a terra e poco dopo un rettangolo di cemento crolla al suolo.
Le azioni di Wood & Harrison si prendono gioco della distanza che il meccanismo della video-ripresa mantiene con il fruitore; la riconoscibilità dell’oggetto avviene definitivamente solo dopo la sua messa in funzione totale, solo dopo che l’intervento umano apporta una forza inusuale e ingiustificata, per mostrarne la vera natura.
Lo studio della fisica sembra applicarsi ad “arte” o, per meglio dire, a videoarte, e mentre la coppia inglese si misura con innaffiatoi verdi straripanti liquido colorato, secchi neri appesi a un filo e scale di metallo da cui testare il proprio equilibrio di forze, due piccoli schermi proiettano 66.86m a destra e 100m a sinistra, in loop, per la durata di poco più di tre minuti ciascuno.
I due video che circondano l’opera principale non si avvalgono della presenza degli artisti. Il primo gioca con intrecci di fili bianchi, a tratti neri, che si scontrano come laser perpendicolari, fino a formare il contorno di una sedia; il secondo riprende una ventola sul soffitto che, all’interno di una stanza, bianca anch’essa, cerca di attrarre a sé un rettangolo di compensato marrone.
L’effetto acustico che completa le tre video-installazioni è delicato, minimale, quasi impercettibile, quel tanto che basta per ronzare nella mente del visitatore, ormai ipnotizzato dal candore della galleria e delle mura dei Twenty six drawing. Ma perché si parla di disegno quando ciò che si vede è frutto della loro stessa immagine, ripresa da una videocamera? La matita è alla base di tutto: piccole bozze aiutano il duo a disegnare uno storyboard di azioni, sfidando la resistenza superficialmente constatata del mondo degli oggetti nello spazio.
Flavia Montecchi