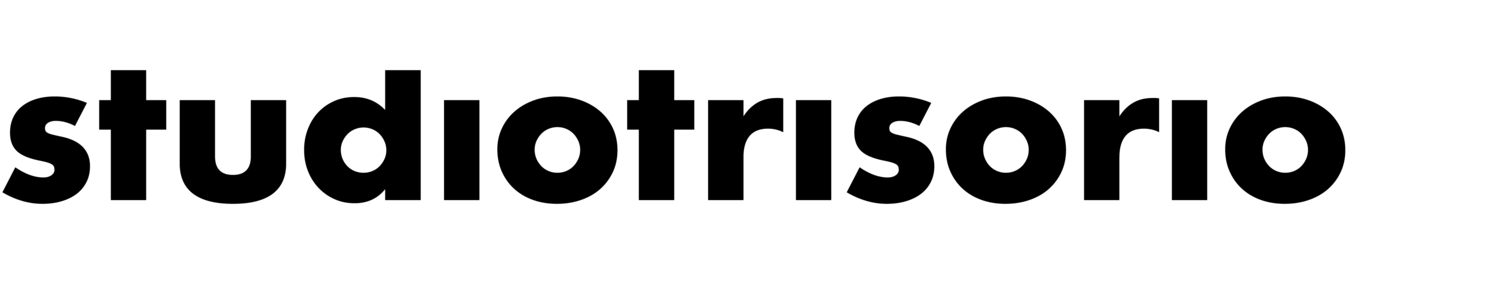Daniel Buren
segno / ottobre — novembre 2008
Daniel Buren è comunemente considerato, a pari merito almeno con Michael Asher, Marcel Broodthaers, Christo ed Hans Haacke, tra i fondatori della “critica istituzionale” a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70. Celeberrima è, a tale proposito, la censura del suo enorme stendardo, presentato in occasione della sesta edizione della Guggenheim International Exhibition. Un provvedimento istigato da alcuni tra gli altri artisti presentati in mostra (per lo più i minimalisti americani) che accusavano l’artista francese di oscurare le loro opere con l’invadenza del suo intervento. Un pretesto dietro al quale sembrava celarsi un conflitto più profondo tra due diverse concezioni dello spazio museale. All’astratta neutralità di uno spazio concepito come puramente visivo e fenomenologico (questa la visione di Donald Judd o di Dan Flavin, ad esempio), Buren contrapponeva una teoria che intendeva lo spazio come connotato in primis da interessi ideologici ed economici.
Oggi come allora, benchè la valenza iconoclasta delle origini appaia ora non più così marcata, Buren fonda le sue indagini sui rapporti tra opera, spazio e spettatore sull’alternanza di strisce bianche e colorate, vero e proprio logo della sua produzione. Esse infatti, definite “utensili visivi” prima ancora che costruire riduzioni al grado zero della pittura (si rammentino le ricerche condotte, in tal senso in Francia, tra il ‘66 ed il ‘67, dal gruppo BMTP, cui Buren diede vita insieme ad Oliver Mosset, Michel Parmentier e Niele Toroni), possedevano fin da principio la semplice funzione di richiamare l’attenzione dell’osservatore sugli elementi del reale, di sottolinearne l’esistenza tanto in luoghi chiusi che nello spazio pubblico, ove spesso subivano la sorte della consunzione, dimostrando l’importanza del contesto nel processo di attribuzione di significato dell’opera.
In occasione della personale in esame, il cui titolo Oggi, qui sembra indicare la volontà di sottolineare l’interazione, ora osmotica ora antitetica, che la sua poetica costantemente ricerca con il contesto espositivo, Buren abbina a tali emblematiche strisce un motivo a scacchiera, anch’esso comunque non senza precedenti nell’ambito del suo percorso. Alle pareti si alternano così quadrati bianchi a quadrati di cinque differenti colori (arancione, azzurro, giallo, fuxia e verde). Una nuova prepotente affermazione, stando alle sue intenzioni, dell’irriducibilità del colore a qualunque altro strumento linguistico, seguendo di appena quattro anni un altro importante saggio fornito dall’artista in tal senso a Napoli: il palazzo dell’Arin di Ponticelli, quartiere periferico posto nella zona orientale della città. Buren tuttavia, dimostrando di conservare ancora viva la coscienza dell’inevitabile interscambio tra discorso artistico condizionamenti istituzionali, mette in guardia da un’arte che strumentalizzi il colore per occultare il disagio, che la porrebbe in una posizione di connivenza con le forze conservatrici. Non di meno il confine tra un’arte che si esplichi con una valenza decisamente progressiva e democratica ed un potere che inglobi le sue espressioni all’interno delle strategie di dominio rimane oggi più che mai incerto.
Stefano Taccone