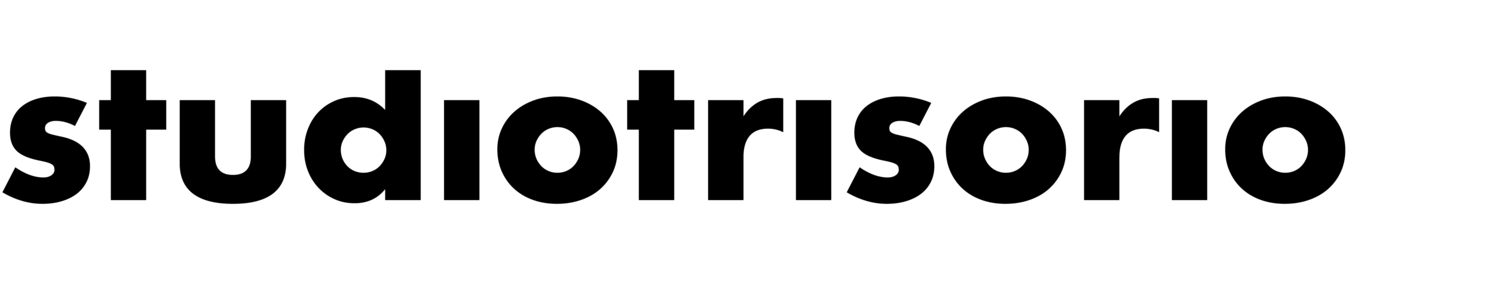Vedi Napoli (con Jan Fabre) e poi muori
la repubblica / 29 giugno 2019
L’artista a Capodimonte e non solo
Era fatale che prima o poi Jan Fabre, l’artista belga che ha fatto dei lucenti esoscheletri degli scarabei uno dei suoi principali mezzi espressivi, si arrendesse alla fascinazione del corallo: in fondo un filo lega queste due forme così dissimili del regno animale, che si proteggono dietro solidi scudi di stupefacente bellezza e non a caso occupano posti di tutto rilievo nella regione dei simboli e dei miti. Ed era inevitabile che quest’incontro avvenisse a Napoli, città che Jan Fabre da qualche anno frequenta e occupa con mostre e installazioni.
La mostra Oro rosso a Capodimonte (fino al 15 settembre) sembra la logica conclusione di un percorso iniziato molto tempo fa. Fabre si è avvalso della sapienza dei grandi artigiani locali per dare un nuovo corpo scarlatto alle sue ossessioni. Ed ecco comparire nelle sale del museo una spiazzante gioielleria barocca: teschi fiammeggianti, autoritratti dell’artista, grandi spade alate (angeliche o diaboliche) e croci vermiglie da cui sembrano nascere rami e foglie, come fossero alberi. Ma se qualcuno di questi oggetti può sembrare troppo curato e prezioso, perfino lezioso, nei grandi cuori la scultura raggiunge invece la sua piena forza evocatrice: perché qui la materia del corallo è perfetta, è sangue che scorre e si avviluppa in spire, ramificazioni, intrecci, e sembra pulsare anche nella sua fissità. Oro rosso è il nome del corallo, ma è un termine che si addice bene anche al sangue: ed è bello che l’artista abbia tirato fuori dal cassetto – per l’occasione – una serie di carte realizzate a prezzo del suo sangue negli anni Ottanta: si chiamavano My body, my blood, my landscape, Je suis sang, Mantis/Sanguis e sono un diario intimo ma pubblico che mostra i temi cari a Fabre: il corpo, la ferita, la religiosità, una cerimonialità mistica in cui il sacrificio – l’uso del proprio sangue, appunto – diventa centrale. Tra questi c’è anche la serie dei Prayer card collage drawings, mai esposta prima: disegni insanguinati sui santini che la religiosissima madre regalava al figlio. Sono carte spettinate e potenti, molto espressive e dirette: mezzi poveri (a confronto dell’oro e del corallo che brilla a fianco), ma sufficienti a creare una lingua ricchissima. Che pulsa anche in altri luoghi della città: quella di Fabre è infatti una mostra diffusa.
Il tetto del museo Madre ospita (fino al 30 settembre) una versione in marmo bianco de L’uomo che misura le nuvole e lo Studio Trisorio (fino al 30 settembre) i bellissimi Tributi al Congo belga, (grandissimi quadri realizzati con gli scudi degli scarabei che dietro un manto di smagliante compostezza formale denunciano la violenza della colonizzazione).
Infine c’è il Pio Monte della Misericordia, casa delle Sette opere di Misericordia di Caravaggio, capolavoro che avrebbe dovuto essere spostato a Capodimonte in occasione della mostra sul maestro. Fabre vi ha collocato un autoritratto a grandezza naturale. Era un’installazione destinata a coprire in qualche modo il vuoto lasciato dal Caravaggio: ma ora quell’uomo di cera che erge una grande croce sembra sbarrare il passo al trasferimento del dipinto, che infatti è stato bloccato. Una profezia, più che una scultura.
Gregorio Botta